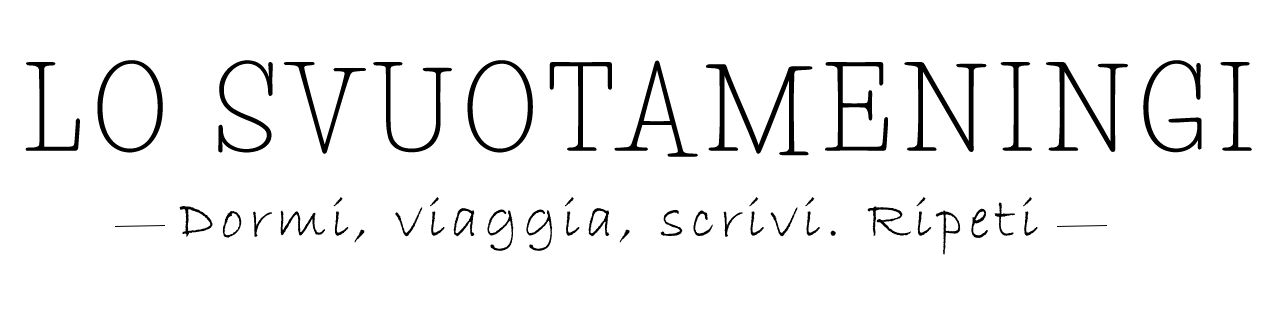Quel gabbiano nel cielo nero
Camminavo lungo il litorale, a ogni passo mi appoggiavo su un bastone di mogano nero, zoppicavo.
Davanti a me vedevo bambini rincorrersi con in mano palette e secchielli, due giovani ragazzi correre con il fiatone, una donna con il telefono tra l’orecchio e la spalla destra, intenta a caricare le buste della spesa in macchina.
Io credo che prima o poi si arrivi a un punto nella nostra vita in cui tutto il mondo attorno a noi sembra accelerare, mentre noi rallentiamo, fino a fermarci. Come la pioggia che dopo aver colpito violentemente la terra rallenta fino a smettere, lasciando il posto alla pace, così la nostra vita prosegue fino a quando decide di fermarsi.
Continuai per qualche metro fino ad arrivare ad una panchina di pietra. Era fredda ma accogliente. La pietra mi cingeva in una morsa, probabilmente fatale.
Di fronte a me il mare, che nella sua immensità abbracciava tutto il mio orizzonte.
Il sole era ancora basso: saranno state le nove, forse le nove e mezzo. Avere in faccia quei primi tiepidi raggi di luce non m’infastidiva, anzi, mi accarezzavano dolcemente dandomi quel calore che il tempo mi aveva tolto lentamente: il calore di una famiglia. Chiusi gli occhi per un momento, ma nel riaprirli feci fatica.
Dovevo riuscirci, dovevo resistere, dovevo battere la malattia almeno un’ultima volta. L’Alzheimer è la malattia peggiore che si possa avere perché non ti crea lesioni fisiche ma mentali, ti logora dall’interno, mangiandoti pian piano, fino a farti perdere la cosa più importante: la tua vita.
Chiusi ancora gli occhi. Sentivo le risate dei bambini, i passi pesanti di chi corre ormai da ore, il fragore delle onde che s’infrangono contro le rocce, il batter d’ali dei gabbiani.
Tornai indietro con i ricordi di settant’anni, era il mio sesto compleanno e avevo davanti una semplice torta con sei candeline posate delicatamente sulla cialda da mia madre.
Mio padre non c’era, ma in fondo lui non c’è mai stato; non ho mai saputo neanche come fosse la sua faccia, il suo sorriso.
Non ho mai avuto nessuno che mi portasse allo stadio, nessuno che m’insegnasse come attaccare bottone con una ragazza, nessuno che fosse lì quando presi il mio primo pugno o ruppi il primo vetro con il pallone.
Mia madre non me lo ha fatto mai pesare, ma per lei non deve essere stato facile tirarmi su da sola. Ma l’ha fatto, e per questo le sarò sempre grato.
I ricordi scorrevano via velocemente: la prima pedalata in bicicletta, la prima nuotata, il primo giorno di scuola, la prima giornata di lavoro, la prima ragazza, il primo bacio, la prima scopata.
Tutto mi passava davanti come un fiume in piena, travolgendomi. Era da molto che non provavo questa sensazione, la sensazione di essere padroni della propria vita, del proprio passato.
Quel fiume sfociava in un lago, non molto grande ma profondo; è il lago di Lara, la mia prima cotta. Decisi di tuffarmi, di rivivere quel momento, pur non avendo molto tempo.
Avevo quattordici anni, e mia madre mi aveva affidato per la prima volta il compito di comprare il pane. Con i miei pantaloni marroni a pinocchietto e una canottiera bianca mi presentai dal fornaio del mio paese saltellando felice; finalmente mi ritenevano abbastanza grande per fare qualcosa. Entrai e vidi un omone con i folti baffi ed un grembiule bianco sporco di farina. Appena mi vide mi sorrise e mi chiese chi fossi.
Risposi alla domanda e accertate le mie “credenziali” mi chiese che pane volessi. Stavo per uscire quando la vidi, forse attirata in quella stanza dalla mia voce piena d’entusiasmo o forse complice il destino.
Era bellissima, bionda, con una treccia adagiata con cura sulla spalla destra. Aveva gli occhi nocciola e una voce dolce come lo zucchero filato.
Da quel giorno andai ogni mattino per almeno tre mesi a prendere il pane, nella speranza di incontrarla.
La vedevo quasi tutti i giorni, quando sentiva la mia voce, affacciarsi dalla porticina che collegava la bottega ad un’altra stanza; si affacciava, arrossiva e spariva lasciando solo l’immagine della sua figura fissa nella mia mente. Pensavo in continuazione a lei, quando un giorno mi decisi a rivolgerle la parola. Ma entrando non trovai il solito omone allegro con i suoi folti baffi, né sua figlia affacciata alla porticina.
Trovai il garzone, e in risposta alla mia faccia stranita mi disse che il fornaio e sua figlia stavano partendo per andare in un altro paese.
Corsi come non avevo mai corso, la stazione distava solo tre chilometri, ma a me sembravano mille.
Correvo scalzo e caddi.
Mi rialzai ed arrivai con il fiatone, giusto in tempo per salutarli.
Il fornaio mi sorrise e mi strinse forte, quasi soffocavo. Ma appena sentì il treno fischiare si staccò, prese i due borsoni e disse a Lara che era tardi, che stavano per partire. Lei si avvicinò e mi stampò un bacio sulla guancia; m’infilò la mano nella tasca destra e fuggì.
Mi aveva lasciato una …
Non feci in tempo a guardare cosa avevo in tasca che fui sospinto fuori dal laghetto, da una corrente d’acqua e riportato in superficie; era ora di andare avanti, non c’era molto tempo.
Continuai a percorrere il fiume: il primo stipendio, il primo regalo che comprai a mia madre, i miei diciotto anni.
Vidi un altro ricordo e decisi di seguirlo, era la mia anima gemella, Camilla. Io ero lento e pesante, lei veloce e schivava facilmente gli altri ricordi minori. Ma ero deciso a ricordare e neanche la malattia sarebbe riuscita ad impedirmelo. Con un balzo vi entrai dentro e la prima cosa che vidi fu il suo viso. Felicità, sconforto, nostalgia, dolore, stupore; provai tutto insieme, come uno schiaffo che non fa male, non lo senti sulla pelle, ma lo senti dentro, come una morsa d’acciaio che ti stritola.
Avevo vent’anni, lei diciannove.
Ci incontrammo un anno prima di partire per la leva obbligatoria.
Ero a una festa, nulla di speciale, qualche faccia conosciuta e qualche imbucato. Musica lenta, luci soffuse, alcool. I classici anni ’50.
Me la ritrovai davanti e senza esitare mi presentai, progettando già al dopo-festa.
La giovane età, sempre spavaldi e senza remore, sempre pronti a fare il passo più lungo della gamba.
Ma ciò che io cercavo non corrispondeva esattamente ai piani di Camilla. Capii forse troppo tardi che lei non fosse una di quelle ragazze in cerca di un’avventura, solo dopo aver avvicinato troppo la mia faccia alla sua.
Uno schiaffo mi colpì in pieno volto. Me lo diede così forte che si sentì in tutta la sala.
Bofonchiai delle scuse forse incomprensibili e decisi di tornare a casa, con la guancia pulsante e la consapevolezza di essermi comportato come un coglione. Feci appena in tempo a superare il cancello della casa che sentii la porta d’ingresso aprirsi, e lì, girandomi, la vidi uscire, puntando dritta verso di me. quando la vidi uscire.
Pensai che volesse pareggiare la mia faccia con l’altra guancia, invece no.
Si limitò a tendermi un fazzoletto con sopra il suo indirizzo di casa.
“La prossima volta che ci vedremo, magari inizia col chiedermi di prendere un caffè”.
Forse lo schiaffo sarebbe stato meno umiliante, ma presi il fazzoletto, e andai via.
Due settimane dopo mi presentai a casa sua, e le chiesi di uscire.
Due mesi dopo, stavamo insieme.
Fu il periodo più bello della mia vita, un periodo nel quale non avevo bisogno di nient’altro, come quando finisci di mangiare e guardi il piatto vuoto, con la pancia piena.
Passammo insieme un anno prima che arrivasse la chiamata alle armi.
Partii con la consapevolezza che mi avrebbe aspettato, e così fu.
Continuai su quel fiume che diveniva via via più magro, più vuoto; dovevo resistere. A un certo punto vidi l’acqua sporca, quasi nera, mi avvicinai e ricordai qualcosa che avrei voluto non ricordare mai.
Dopo undici mesi dal mio arruolamento fui richiamato dal servizio. Inizialmente non mi dissero il perché, ma dopo aver visto le loro facce serie, capii che era successo qualcosa.
Mia madre era morta nel sonno, a soli quarantanove anni. Mi crollò il mondo addosso, come una frana che non fa rumore, durante la notte.
Ero appena riuscito a dare un senso alla mia vita, a costruire un castello di carte, ed il vento senza preoccuparsene me lo aveva spazzato via.
Rimaneva solo una carta in piedi, la regina di fiori, Camilla.
Uscii a fatica da quell’acqua sporca. Ero stanco, molto stanco.
In quella panchina fredda sul litorale era seduto un vecchio, con gli occhi chiusi, immobile, mentre il sole era alto.
Continuavo a seguire il fiume, ma non riuscivo a vedere più il fondo, avevo la vista appannata, cercai e trovai un ultimo barlume di lucidità e mi gettai nel ricordo più grande, nella pozza più profonda.
Una casa familiare, un bambino che correva scalzo sul pavimento di legno, una donna bella, bionda che cucinava.
Un uomo con il mio viso, ringiovanito di quarantanni, con la mia voce, ripeteva la frase “Marco, il pranzo è pronto”.
Il bambino arrivò con un aeroplanino in mano e un sorriso stampato sul viso. Era una famiglia felice, c’erano maccheroni al formaggio quel giorno. C’era un’altalena nel giardino, era sospinta dal vento e cigolava; era la stessa nella quale passai tanti pomeriggi a ripetere l’alfabeto con mia madre che, vigile, mi spingeva dolcemente.
Ora era lì, arrugginita, ma sempre in piedi, sorretta da quell’albero che mi aveva visto crescere, ridere, correre, sbucciarmi le ginocchia.
Avevo trentacinque anni, una promettente carriera come giornalista davanti, una moglie perfetta, un figlio di cui ogni padre dovrebbe essere orgoglioso.
Avevo una vita. Nonostante tutte le difficoltà incontrate da bambino ci ero riuscito, ero riuscito a costruire il mio sogno.
L’acqua però iniziava a farsi fredda e riuscivo a stento a stare dentro il ricordo, ma strinsi i denti e resistetti.
Era il 26 aprile, sembrava una giornata come le altre, solita doccia, solita colazione con cornetto e cappuccino.
Marco doveva andare allo zoo nel paese vicino e Camilla lo avrebbe accompagnato. Marco voleva lo portassi io, ma avevo una riunione importante e gli dissi che ci saremmo andati un’altra volta.
Mi guardò dritto negli occhi e mi fece promettere che quella settimana lo avrei portato al circo a vedere i clown; mi strinse il dito indice come sigillo per la promessa e andò via sgambettando.
Mentre andavano allo zoo, un grosso camion perse il controllo e andò a sbattere violentemente contro la macchina dove viaggiavano Camilla e Marco.
Mi chiamarono e mi dissero quanto era accaduto; mi precipitai lì ma quando arrivai, non c’era altro che pezzi di lamiera, vetri infranti e un aeroplanino, sulla strada.
Mi dissero che l’impatto era stato così violento che non mi sarebbe stato possibile neanche andare a vedere le salme in obitorio.
Il mio castello crollò definitivamente, ma questa volta sul tavolo non rimanevano carte, solo l’immagine di quello che era e che non potrà più essere.
Iniziai a bere, a trascurare il lavoro, a dimenticarmi degli articoli, delle interviste, dell’altalena, del viso di mia moglie, di Marco, del circo, l’aeroplanino.
Vivevo solo, senza nessuno ad aiutarmi, nessuno con cui parlare.
Vivevo con le foto, ma quando anche le foto iniziarono a sbiadire, rimaneva solo quel sapore di amaro in bocca, lo stesso sapore che si ha quando si viene superati all’ultimo secondo, lo stesso sapore che ha chi un momento prima toccava il cielo con un dito ed un secondo dopo il suolo con il culo.
Quando arrivò l’Alzheimer, avevo solo cinquantotto anni; dimenticavo le chiavi, di pagare le bollette, di spegnere la luce, di chiudere la porta. Peggiorai e iniziai a dimenticare come si cambia la marcia, come si nuota, come si accende la radio. Vivevo tra libri, libri e nient’altro, leggevo storie di altre persone, arrivando a credere che fossero le mie storie, le tante storie della mia vita.
Ero morto, morto dentro, vivo solo nel corpo, l’anima lacerata da tanti episodi orribili. Continuavo a sopravvivere, ma ero stanco e così un giorno decisi di farla finita.
Salii sul tetto e mi gettai di sotto; ma non trovai il suolo, solo un ramo dell’albero che era cresciuto con me. Era il ramo dell’altalena, che si spezzò e cadde con me, salvandomi la vita.
Ero vivo e con stupore guardavo quell’altalena a terra, quasi volesse parlarmi, dirmi che prima dovevo fare ancora qualcosa: ricordare.
Ci misi del tempo, degli anni. Anni di fallimenti, di terapie inutili e ciarlatani. I momenti di lucidità mi permettevano di ricordare piccoli momenti, ma mi sentivo un estraneo, senza passato o identità.
Fino a quando un giorno, riuscii a farcela, seduto su una panchina nel litorale.
Capii che era giunto il momento; lo sentivo, lo desideravo.
Avevo la mia vita, ne ero il padrone.
Finalmente potevo lasciare quello scrigno pieno di dolore e sofferenza. Avrei potuto rivedere mia madre, Marco e Camilla, avrei potuto conoscere mio padre e andare allo stadio con lui a vedere gli angeli giocare.
M’infilai la mano nella tasca destra ed estrassi tre oggetti: la prima moneta che mi aveva lasciato mia madre per comprarmi un gelato, una vecchia foto in bianco e nero di una bambina con una treccia e un sorriso più grande del cielo, e un aeroplanino, piccolo e ammaccato, un aeroplanino che non sarebbe dovuto stare nelle mie mani.
Chiusi gli occhi, ma nonostante ciò potevo vederlo, nel grande cielo nero della mia mente.
Sentivo che arrivava, ma io non avevo perso.
Aspettavo quel piccolo gabbiano bianco, per andare verso il sole, verso il suo caldo abbraccio.
Sorrisi, accogliendo la pace come una vecchia amica.
Mamma, Camilla, Marco, Papà, arrivo.
Aprii gli occhi e mi ritrovai al litorale, il sole era come l’avevo lasciato, non saliva più, ma scendeva, lentamente, come se mi stesse aspettando da ore, il tempo si era quasi fermato e non c’era nessuno sulla spiaggia.
Alzai lo sguardo e lo vidi. Vidi un gabbiano planare sull’acqua maestoso come una montagna, ma leggero come una piuma.
Veniva verso di me con calma, sapeva che l’avrei aspettato.

La cieca verità

L'orsacchiotto
Potrebbe interessarti

Handy
25 Agosto 2019
Robot di carne
13 Dicembre 2019